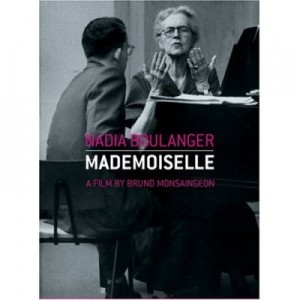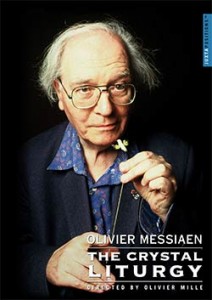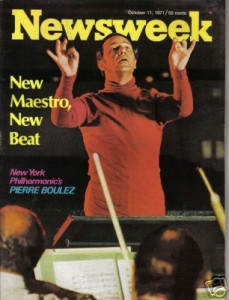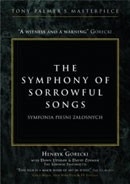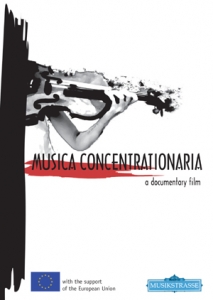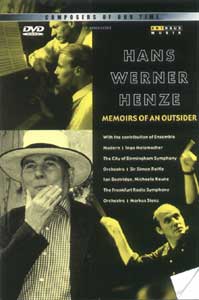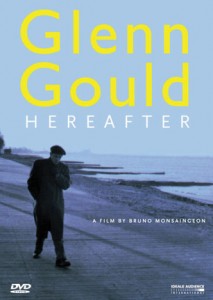25 Giugno 2009 § § permalink

Fare un film su una composizione musicale è un compito difficile e pericoloso per un regista; farlo non avendo alcuna intenzione di illustrare, ma con il coraggio di aggiungere una sceneggiatura e una drammaturgia alla musica ed eventualmente al testo cantato, è un caso più unico che raro. Lascia dunque abbastanza stupiti scoprire la bellezza di un film come War Requiem di Derek Jarman, e accorgersi di quanto poco sia stata considerata questa pellicola fuori dalla Gran Bretagna, da parte sia degli appassionati di cinema sia da quelli di musica. Eppure non si tratta di un’opera minore; anzi, qualcuno sostiene che si tratti del suo massimo capolavoro.

Girato da Jarman e prodotto da Don Boyd nel 1989, War Requiem è una grandiosa lettura visuale e drammatica della composizione che Benjamin Britten scrisse nel 1961–62 per l’inaugurazione della cattedrale di Coventry restaurata dopo le bombe incendiarie sganciate dalla Luftwaffe nel 1940. Fatta eccezione per un lungo piano sequenza iniziale, la sua storia si dispiega sulla incomparabile incisione che Britten stesso ne fece, con l’amato Peter Pears, Dietrich Fisher-Dieskau e Galina Vishnevskaya nel 1963 (l’orchestra era la London Symphony); un tenore inglese, un baritono tedesco e una soprano russa, a rappresentare le tre grandi nazioni in guerra (anche se alla prima esecuzione, quella avvenuta nella nuova cattedrale di Coventry il 30 maggio del 1962, alla Vishnevskaya era stato impedito di partecipare dal ministro della cultura sovietico). Britten non era certo la persona più adatta né alle solenni celebrazioni di marca guerriera, né alle grandi architetture religiose, e come si sa ne ricavò una delle opere di più profonda e radicale denuncia nei confronti dell’assurdità e crudeltà della guerra che mai sia stata fatta attraverso la musica; una straordinaria riflessione sulla violenza, la morte, l’amore e la poesia che mi sembra non avere paragoni nell’intera storia della musica.

Al testo latino della messa di Requiem, con il quale da ateo non si sentiva presumibilmente a proprio agio, Britten scelse di inframmezzare alcune poesie del più straziante e lirico dei poeti-soldati della prima guerra mondiale, Wilfred Owen, morto al fronte in circostanze tragiche una settimana prima della firma dell’armistizio. Si tratta di poesie che appartengono al cuore della letteratura inglese sulla Grande Guerra, intrise di un senso della pietà e di non pacificato dolore che rappresentarono il più violento urlo contro l’assurdità bellica che la letteratura dell’epoca abbia creato: il famoso Anthem for Doomed Youth (Inno per la gioventù condannata), o The Parable of the Old Man and the Young (La parabola del vecchio e il giovane), aspro sovvertimento del sacrificio di Isacco, o ancora la straordinaria, incompleta Strange Meeting (Strano incontro), in cui è descritto un allucinato e commovente incontro con un soldato nemico, sono liriche che racchiudono il pensiero di Britten sulla guerra più di qualsiasi dichiarazione genericamente pacifista. » Read the rest of this entry «
30 Giugno 2008 § § permalink
 È difficile sopravvalutare l’influenza che Nadia Boulanger ha avuto sulla musica del Novecento. I suoi Mercoledì, durante i quali una cinquantina di studenti e ammiratori, celebri e meno celebri, invadevano il celebre appartamento di rue Ballu 36 – una casa letteralmente traboccante di libri, partiture, strumenti, fotografie e cimeli – sono ormai entrati nella leggenda. “Mademoiselle”, come era affettuosamente definita, vi teneva banco con le sue dottissime analisi, gli ascolti di nuove composizioni, la conversazione sempre elevata e brillante, ma in nessun caso sciatta o salottiera; con i suoi occhiali a pince-nez, così professorali e inconsueti su un volto femminile; con la sua profonda intimità intellettuale con molte delle maggiori menti artistiche del secolo. Fauré, Stravinsky, Valèry, Cocteau, Gershwin, Bernstein, la principessa di Polignac, Szeryng fra i tantissimi frequentatori; un’intera generazione di compositori americani tra i suoi allievi (gli “americani a Parigi” degli anni Venti): Carter, Copland, Piston, Thomson ecc., ma anche molti direttori d’orchestra (Baremboim e Gardiner per fare tre nomi “recenti”); pianisti, come il grande Dinu Lipatti; ma osservare la lista dei frequentatori e degli allievi è sorprendente per l’impressionante escursione temporale e culturale dei suoi ammiratori, da Jaques Ibert a Piazzolla, da Menotti a Philip Glass o a Quincy Jones. Prima donna a dirigere una grande orchestra come la New York Philarmonic, Nadia Boulanger ha rappresentato per anni il concetto stesso di cultura musicale; poi qualcosa ha cominciato a cambiare. La sua distanza dalle tecniche della serialità (distanza nutrita di rispetto e di competenza, come sempre nel suo caso) l’ha resa invisa ai giovani rampanti degli anni Sessanta e Settanta, Boulez in testa, che cominciarono a parlare sprezzantemente del suo entourage come di un mondo di bolsi accademici (la “boulangerie” lo definivano, con una battuta che grazie alla sua facile rozzezza diventò presto celebre).
È difficile sopravvalutare l’influenza che Nadia Boulanger ha avuto sulla musica del Novecento. I suoi Mercoledì, durante i quali una cinquantina di studenti e ammiratori, celebri e meno celebri, invadevano il celebre appartamento di rue Ballu 36 – una casa letteralmente traboccante di libri, partiture, strumenti, fotografie e cimeli – sono ormai entrati nella leggenda. “Mademoiselle”, come era affettuosamente definita, vi teneva banco con le sue dottissime analisi, gli ascolti di nuove composizioni, la conversazione sempre elevata e brillante, ma in nessun caso sciatta o salottiera; con i suoi occhiali a pince-nez, così professorali e inconsueti su un volto femminile; con la sua profonda intimità intellettuale con molte delle maggiori menti artistiche del secolo. Fauré, Stravinsky, Valèry, Cocteau, Gershwin, Bernstein, la principessa di Polignac, Szeryng fra i tantissimi frequentatori; un’intera generazione di compositori americani tra i suoi allievi (gli “americani a Parigi” degli anni Venti): Carter, Copland, Piston, Thomson ecc., ma anche molti direttori d’orchestra (Baremboim e Gardiner per fare tre nomi “recenti”); pianisti, come il grande Dinu Lipatti; ma osservare la lista dei frequentatori e degli allievi è sorprendente per l’impressionante escursione temporale e culturale dei suoi ammiratori, da Jaques Ibert a Piazzolla, da Menotti a Philip Glass o a Quincy Jones. Prima donna a dirigere una grande orchestra come la New York Philarmonic, Nadia Boulanger ha rappresentato per anni il concetto stesso di cultura musicale; poi qualcosa ha cominciato a cambiare. La sua distanza dalle tecniche della serialità (distanza nutrita di rispetto e di competenza, come sempre nel suo caso) l’ha resa invisa ai giovani rampanti degli anni Sessanta e Settanta, Boulez in testa, che cominciarono a parlare sprezzantemente del suo entourage come di un mondo di bolsi accademici (la “boulangerie” lo definivano, con una battuta che grazie alla sua facile rozzezza diventò presto celebre).
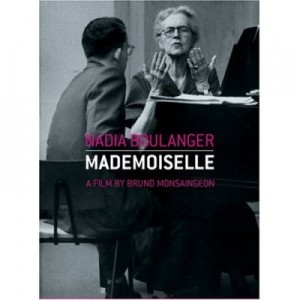 È una storia che ci viene oggi raccontata dal riversamento in DVD di un film del 1977 di Bruno Monsaingeon intitolato proprio Mademoiselle, e girato su pellicola in b/n in occasiuone dei novant’anni della Boulanger. Il film dura 80 minuti circa, e se non fosse per il suo altissimo valore documentario si potrebbe dire che è un’opera minore di questo grande regista documentarista. Ma assistere a una lezione della Boulanger, già molto anziana, ascoltare il suo francese coltissimo e perfetto, ammirare l’esibizione naturale e continua di “clartè” del suo pensiero, la prontezza con cui risponde alle domande, a volte un po’ fumose o vagamente petulanti, dell’intervistatore ne fanno uno spettacolo straodinario. Accompagnano la visione due commentatori d’eccezione: il misterioso Igor Markevitch, e il grande Leonard Bernstein, naturalmente seduto al pianoforte.
È una storia che ci viene oggi raccontata dal riversamento in DVD di un film del 1977 di Bruno Monsaingeon intitolato proprio Mademoiselle, e girato su pellicola in b/n in occasiuone dei novant’anni della Boulanger. Il film dura 80 minuti circa, e se non fosse per il suo altissimo valore documentario si potrebbe dire che è un’opera minore di questo grande regista documentarista. Ma assistere a una lezione della Boulanger, già molto anziana, ascoltare il suo francese coltissimo e perfetto, ammirare l’esibizione naturale e continua di “clartè” del suo pensiero, la prontezza con cui risponde alle domande, a volte un po’ fumose o vagamente petulanti, dell’intervistatore ne fanno uno spettacolo straodinario. Accompagnano la visione due commentatori d’eccezione: il misterioso Igor Markevitch, e il grande Leonard Bernstein, naturalmente seduto al pianoforte.
Racconta Monsaingeon nelle note di copertina che originariamente il film si apriva con una scena di Love Story, il film drammatico/sentimentale di Arthur Hiller che a partire dal 1970 ha fatto piangere generazioni di innamorati. Nella trama del drammone, lei, la semplice e bellissima musicista (Ali MacGraw), per sposare lui (Ryan O’Neal), ricco e altoborghese, aveva rinunciato alla borsa di studio a Parigi a cui tanto teneva; lui aveva rinunciato al patrimonio di famiglia e alla brillante carriera connessa. La scena, tagliata dal DVD per una questione di diritti, era quella, precedente al sacrificio, in cui lei comunicava a lui che sarebbe partita per la Francia: aveva finalmente ottenuto la possibilità di andare a studiare a Parigi con la celebre Nadia Boulanger. Cosa non si fa per amore.
31 Maggio 2008 § § permalink
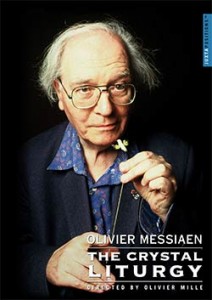
Il prossimo 10 dicembre saranno passati 100 anni dalla nascita di Olivier Messiaen, e gli omaggi hanno da tempo cominciato ad apparire un po’ ovunque. Qui vorrei ricordarne due, di taglio molto diverso: il film di Olivier Mille, intitolato La Liturgie de cristal, del 2002, da poco pubblicato in DVD nella bella collana “Juxtapositions” (The Crystal Liturgy, Ideale Audience 2007), e un buffo quanto incongruo articolo che gli ha recentemente dedicato il «Nouvel Observateur».
Il film di Mille è un bellissimo omaggio. Comincia con una lunga sequenza di canyon dello Utah, per poi ripercorrere la vita creativa di Messiaen per ampi capitoli, utilizzando frammenti di interviste, scene di paesaggio ed esecuzioni musicali. Ci sono tutti gli aspetti della lunga e per molti versi sorprendente vita di Messiaen: l’ornitologo serissimo, appassionato, spesso quasi infastidito dalla sufficienza con cui talvolta era (e per molti versi tuttora è) considerato questo aspetto della sua creatività. Lo studioso di discipline filosofiche e spirituali, con il capitolo sul Giappone, e l’indissolubile legame con le immagini e i motivi della fede cattolica. Messiaen compositore, dalla classe di Dukas alle prime creazioni, il campo di prigionia e la genesi del Quatuor puor la fine du temps, poi le tante fasi e la straordinaria ricchezza e varietà del suo catalogo, compreso il periodo americano e il vasto affresco di Des Canyons aux Etoiles (con delle belle riprese del Mount Messiaen, la montagna che gli fu dedicata nello Utah nel 1978). E ancora: Messiaen didatta, con gli interessanti frammenti di lezione al Conservatorio. E sopra tutto, molta bellissima musica, dal Catalogue des oiseux al San Francesco d’Assisi. Tutto in un’ora, sinteticamente riassunto ma non imbottito d’informazioni. Il DVD comprende anche tre frammenti di un precedente documentario di Mille su Messiaen, Des canyons aux étoiles, le Mode d’Olivier Messiaen, del 1997, fatto di interviste a interpreti, amici e allievi. Un invito ad approfondire e a conoscere, proprio come dev’essere un omaggio.
 Nei tanti inserti di intervista si ritrova il Messiaen immaginifico, quasi serioso nelle spiegazioni – ma con un filo di spirito sornione e un vistoso piacere nell’essere ascoltato e ammirato – intelligente e privo del timore di sembrare presuntuoso. Le prime parole che gli si sente dire sono:
Nei tanti inserti di intervista si ritrova il Messiaen immaginifico, quasi serioso nelle spiegazioni – ma con un filo di spirito sornione e un vistoso piacere nell’essere ascoltato e ammirato – intelligente e privo del timore di sembrare presuntuoso. Le prime parole che gli si sente dire sono:
Je suis musicien d’abord, bien entendu, compositeur de musique, professeur de composition, organiste, pianiste, aussi rythmicien – j’ai fait des études particulier des rythmes, surtout sur la métrique grecque et les decî-tâlas de l’Inde antique – mais je suis également ornithologue, et ornithologue professionnel et de métier, et ça fait plus de trente ans que je note des chants d’oiseaux pas seulement en France et dans toutes le provinces de France, mais dans tous les pays où j’ai pu voyager au cours de mes concerts.
La cosa che più piace e sorprende della sua intelligenza, è la capacità di portare all’interno del discorso musicale delle “immagini strutturali” (non saprei come chiamare altrimenti dei procedimenti di composizione basati su impressioni visive e auditive) provenienti da mondi ad essa estranei, fossero mondi della biologia (il canto degli uccelli, prima di tutto, ma anche una certa visione della storia naturale), dell’etnografia (la musica giapponese, il gamelan) o della filosofia e della religione (per esempio l’idea del “principio della vetrata”, cioè dell’utilizzo di una moltitudine di colori allo scopo di comunicare un unico colore complessivo). Tra gli esecutori che il film mostra, Ivonne Loriod (la sua seconda moglie), Kent Nagano (giovanissimo), Pierre-Lauren Aimard, e naturalmente Pierre Boulez.
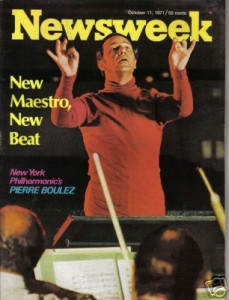 E proprio quest’ultimo trova un modo tutto particolare di ricordare Messiaen in occasione del centenario. Il «Nouvel Observateur» lo intervista in un articolo intitolato “Messiaen, mon Maitre”, e lui ricorda serenamente di aver definito la musica del suo maestro “musique de bordelle”: doveva farlo, era una giusta ribellione, dice. Poi aggiunge anche che in realtà nessuno lo seguiva nelle sue manie, in particolare il canto degli uccelli, la musica religiosa e quella d’organo. È così che Boulez continua a diffondere l’immagine di un bizzarro bigotto, un accademico con dei lati geniali e capace di grandi composizioni, alternate però a delle cose impresentabili e retrive («Messiaen ne compose pas, il juxtapose» ha persino scritto a suo tempo il suo caro allievo). Quanto ha fatto male, alla comprensione di Messiaen questa interpretazione? E perché in Francia non sembra essere possibile liberarsi dei pareri ex chatedra di Boulez? Basta osservare il senso di libera creatività che comunica Messiaen e il chiuso accademismo delle immagini di Boulez direttore per capire che le cose stanno esattamente al contrario. Boulez ha l’aria di un cardinale che officia i suoi misteri con gesti imperiosi e oscuri. Se poi si volessero confrontare le composizioni dei due, beh le cose si mettono anche peggio. Ma è davvero ancora così inevitabile confrontarsi con lui su tutta la musica contemporanea francese?
E proprio quest’ultimo trova un modo tutto particolare di ricordare Messiaen in occasione del centenario. Il «Nouvel Observateur» lo intervista in un articolo intitolato “Messiaen, mon Maitre”, e lui ricorda serenamente di aver definito la musica del suo maestro “musique de bordelle”: doveva farlo, era una giusta ribellione, dice. Poi aggiunge anche che in realtà nessuno lo seguiva nelle sue manie, in particolare il canto degli uccelli, la musica religiosa e quella d’organo. È così che Boulez continua a diffondere l’immagine di un bizzarro bigotto, un accademico con dei lati geniali e capace di grandi composizioni, alternate però a delle cose impresentabili e retrive («Messiaen ne compose pas, il juxtapose» ha persino scritto a suo tempo il suo caro allievo). Quanto ha fatto male, alla comprensione di Messiaen questa interpretazione? E perché in Francia non sembra essere possibile liberarsi dei pareri ex chatedra di Boulez? Basta osservare il senso di libera creatività che comunica Messiaen e il chiuso accademismo delle immagini di Boulez direttore per capire che le cose stanno esattamente al contrario. Boulez ha l’aria di un cardinale che officia i suoi misteri con gesti imperiosi e oscuri. Se poi si volessero confrontare le composizioni dei due, beh le cose si mettono anche peggio. Ma è davvero ancora così inevitabile confrontarsi con lui su tutta la musica contemporanea francese?
22 Marzo 2008 § § permalink
 È da poco apparso in DVD un film di Tony Palmer del 1993, dedicato alla famosa, adorata e disprezzata insieme Terza sinfonia di Henryk Górecki, Symfonia piesni zalosnych, o “dei canti dolorosi”. Per sapere qualcosa di più su questa sinfonia e sull’immenso successo che portò al suo eccentrico autore, consiglio un breve articolo di Norman Lebrecht di poco più di un anno fa. Oggi, con la distanza critica che i quindici anni passati da quell’incredibile exploit consentono, forse si possono tracciare delle linee che rimandano questo brano alla crisi delle avanguardie, e alla nascita nell’Europa dell’Est di moltissime interessanti ricerche libere da qualsiasi vincolo estetico-politico. Non bisogna dimenticare che si tratta di un brano scritto a metà degli anni Settanta, nella Polonia di Jaruzelski, da un compositore inviso al regime, a cui veniva impedita qualsiasi partecipazione agli eventi musicali, qualsiasi possibilità di ascoltare le proprie composizioni più vaste. La sinfonia è insieme grandissima ed elementare, arcaica e post-moderna: può irritare la sua voluta semplicità strutturale e poetica, ma è veramente difficile non lasciarsi commuovere.
È da poco apparso in DVD un film di Tony Palmer del 1993, dedicato alla famosa, adorata e disprezzata insieme Terza sinfonia di Henryk Górecki, Symfonia piesni zalosnych, o “dei canti dolorosi”. Per sapere qualcosa di più su questa sinfonia e sull’immenso successo che portò al suo eccentrico autore, consiglio un breve articolo di Norman Lebrecht di poco più di un anno fa. Oggi, con la distanza critica che i quindici anni passati da quell’incredibile exploit consentono, forse si possono tracciare delle linee che rimandano questo brano alla crisi delle avanguardie, e alla nascita nell’Europa dell’Est di moltissime interessanti ricerche libere da qualsiasi vincolo estetico-politico. Non bisogna dimenticare che si tratta di un brano scritto a metà degli anni Settanta, nella Polonia di Jaruzelski, da un compositore inviso al regime, a cui veniva impedita qualsiasi partecipazione agli eventi musicali, qualsiasi possibilità di ascoltare le proprie composizioni più vaste. La sinfonia è insieme grandissima ed elementare, arcaica e post-moderna: può irritare la sua voluta semplicità strutturale e poetica, ma è veramente difficile non lasciarsi commuovere.
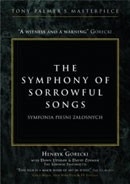 E che dire del film di Palmer? Tony Palmer ha cominciato a girare film sulla musica prima che io nascessi, lavorato con grandissimi registi e fatto cose molto importanti. Come prendere allora un film di cinquanta minuti (la durata della sinfonia) che sovrappone immagini terribili di fame, miseria, disperazione e atroce violenza a quelle della London Sinfonietta diretta da Zinman con la splendida Dawn Upshaw, e a frammenti di intervista con il sornione compositore? Io l’ho trovato detestabile come qualsiasi colpo sferrato sotto la cintura, ma è praticamente impossibile non rimanerne in qualche modo sconvolti. Ho letto che nel 1993, alla prima proiezione del canale televisivo Channel Four (che lo aveva commissionato), fu definito da un dirigente “rubbish”; ma poi fu trasmesso al South Bank Show tra la commozione e le acclamazioni del pubblico. D’altro canto il gioco è terribilmente facile, e se un maestro navigato come Palmer l’ha voluto mettere comunque in atto, è forse perché ha capito che si trattava dello stesso colpo sotto la cintura che la musica di Gorecki sferrava. Andare dritto alla radice del dolore e della compassione, evitando qualsiasi mediazione o barriera difensiva eretta dalla cultura. Detestabile e incredibilmente commovente come può esserlo la musica, dunque; ma comunque non indifferente.
E che dire del film di Palmer? Tony Palmer ha cominciato a girare film sulla musica prima che io nascessi, lavorato con grandissimi registi e fatto cose molto importanti. Come prendere allora un film di cinquanta minuti (la durata della sinfonia) che sovrappone immagini terribili di fame, miseria, disperazione e atroce violenza a quelle della London Sinfonietta diretta da Zinman con la splendida Dawn Upshaw, e a frammenti di intervista con il sornione compositore? Io l’ho trovato detestabile come qualsiasi colpo sferrato sotto la cintura, ma è praticamente impossibile non rimanerne in qualche modo sconvolti. Ho letto che nel 1993, alla prima proiezione del canale televisivo Channel Four (che lo aveva commissionato), fu definito da un dirigente “rubbish”; ma poi fu trasmesso al South Bank Show tra la commozione e le acclamazioni del pubblico. D’altro canto il gioco è terribilmente facile, e se un maestro navigato come Palmer l’ha voluto mettere comunque in atto, è forse perché ha capito che si trattava dello stesso colpo sotto la cintura che la musica di Gorecki sferrava. Andare dritto alla radice del dolore e della compassione, evitando qualsiasi mediazione o barriera difensiva eretta dalla cultura. Detestabile e incredibilmente commovente come può esserlo la musica, dunque; ma comunque non indifferente.
26 Novembre 2007 § § permalink
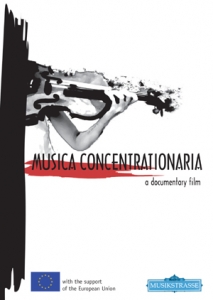 È molto difficile interrogarsi sul significato che la musica può avere per la vita di un uomo quando una tappezzeria sonora riveste interamente le nostre giornate; così come appare sempre più raro riuscire a coltivare quel particolare silenzio interiore che l’ascolto richiede; capita di arrivare trafelati al concerto di un grande artista, e aspettare invano che il turbine della sua grande ala ci sfiori. Assuefatti e rintronati dall’onnipresenza della musica. Ma ascoltare il racconto di chi ha vissuto l’esperienza musicale al limite dell’esperienza umana fa tornare in mente alcuni valori fondamentali, sopiti da quella che potrebbe essere definita “sovrastimolazione estetica”. Musica Concentrationaria è uno strano documentario, nato come parte di un ambiziosissimo progetto condotto dal musicista pugliese Francesco Lotoro: raccogliere tutta la documentazione relativa alla musica composta in prigionia lungo l’intero arco del Ventesimo Secolo, sotto ogni latitudine, e registrarla poi in una sontuosa collana di dischi (24 cd, per la Musikstrasse). In questo DVD sono raccolte una ventina di interviste a sopravvissuti ai campi di prigionia o di concentramento europei, o a loro parenti stretti, e viene documentata la terribile situazione di chi vede dipendere la propria sopravvivenza materiale o anche solo spirituale dall’emozione o dal mestiere del fare musica. Chi ha fatto musica per provare un estremo barlume di libertà o di comunità spirituale, per superare la solitudine e la disperazione di una detenzione inumana e selvaggia, di una condanna a un lavoro stremante e senza speranza; o chi ha dovuto fare musica per allietare i propri aguzzini. Fra questi due poli, l’enorme varietà di esperienze che la musica rende possibili anche “al di fuori” della civiltà da cui si vorrebbe creata. Il DVD ha una regia piuttosto sommaria, fatta con un materiale di base costituito da pochi piani sequenza e tante interviste a camera quasi fissa; eppure, qua e là, momenti di grande emozione. E poi quei visi. I visi di chi ha visto; di chi vorrebbe che non fosse scordato, di chi ha passato un’intera vita a elaborare, e vorrebbe aiutarci a non dovere un giorno ripartire da zero. Prima e ultima testimonianza, quella della grande clavicembalista ceca Zuzana Ruzickova, deportata nel 1941 nel cosiddetto “ghetto di Terezín” (Teresienstadt). Sullo sfondo, la storia incredibile di alcuni grandi compositori che continuarono a fare musica, spesso con straordinario impegno e con importanti risultati, anche quando per loro tutto era perduto, quando persino la fiducia nell’essere umano non poteva che essere svanita: Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, e tanti altri minori, fino ai minimi, a coloro che sapevano solo cantare una canzone, e magari lo facevano in cambio di tre minuti di sospensione del lavoro. Da non dimenticare. Assolutamente, per il bene di tutti.
È molto difficile interrogarsi sul significato che la musica può avere per la vita di un uomo quando una tappezzeria sonora riveste interamente le nostre giornate; così come appare sempre più raro riuscire a coltivare quel particolare silenzio interiore che l’ascolto richiede; capita di arrivare trafelati al concerto di un grande artista, e aspettare invano che il turbine della sua grande ala ci sfiori. Assuefatti e rintronati dall’onnipresenza della musica. Ma ascoltare il racconto di chi ha vissuto l’esperienza musicale al limite dell’esperienza umana fa tornare in mente alcuni valori fondamentali, sopiti da quella che potrebbe essere definita “sovrastimolazione estetica”. Musica Concentrationaria è uno strano documentario, nato come parte di un ambiziosissimo progetto condotto dal musicista pugliese Francesco Lotoro: raccogliere tutta la documentazione relativa alla musica composta in prigionia lungo l’intero arco del Ventesimo Secolo, sotto ogni latitudine, e registrarla poi in una sontuosa collana di dischi (24 cd, per la Musikstrasse). In questo DVD sono raccolte una ventina di interviste a sopravvissuti ai campi di prigionia o di concentramento europei, o a loro parenti stretti, e viene documentata la terribile situazione di chi vede dipendere la propria sopravvivenza materiale o anche solo spirituale dall’emozione o dal mestiere del fare musica. Chi ha fatto musica per provare un estremo barlume di libertà o di comunità spirituale, per superare la solitudine e la disperazione di una detenzione inumana e selvaggia, di una condanna a un lavoro stremante e senza speranza; o chi ha dovuto fare musica per allietare i propri aguzzini. Fra questi due poli, l’enorme varietà di esperienze che la musica rende possibili anche “al di fuori” della civiltà da cui si vorrebbe creata. Il DVD ha una regia piuttosto sommaria, fatta con un materiale di base costituito da pochi piani sequenza e tante interviste a camera quasi fissa; eppure, qua e là, momenti di grande emozione. E poi quei visi. I visi di chi ha visto; di chi vorrebbe che non fosse scordato, di chi ha passato un’intera vita a elaborare, e vorrebbe aiutarci a non dovere un giorno ripartire da zero. Prima e ultima testimonianza, quella della grande clavicembalista ceca Zuzana Ruzickova, deportata nel 1941 nel cosiddetto “ghetto di Terezín” (Teresienstadt). Sullo sfondo, la storia incredibile di alcuni grandi compositori che continuarono a fare musica, spesso con straordinario impegno e con importanti risultati, anche quando per loro tutto era perduto, quando persino la fiducia nell’essere umano non poteva che essere svanita: Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, e tanti altri minori, fino ai minimi, a coloro che sapevano solo cantare una canzone, e magari lo facevano in cambio di tre minuti di sospensione del lavoro. Da non dimenticare. Assolutamente, per il bene di tutti.
16 Novembre 2007 § § permalink

A diciassette anni dalla sua scomparsa, Lenny Bernstein non finisce di rappresentare una gallina dalle uova d’oro per l’industria discografica e una fonte di scoperte e piaceri per gli appassionati di musica. La diffusione del DVD ha fatto sì che le sue centinaia (o migliaia?) di ore di registrazione video possano uscire poco alla volta, continuando a riservare delle sorprese al grande pubblico. L’ultima serie di DVD pubblicata dalla Deutsche Grammophon comprende, per esempio, una bella integrale delle Sinfonie di Brahms, un documentario sulla vita di Bernstein e questo curioso “saggio” video: The Little Drummer Boy: an Essay on Gustav Mahler. Girato nel 1984 a più riprese e in diversi luoghi, è una lunga lezione di Bernstein sulla componente ebraica nella musica e nella vita interiore di Mahler. Una lettura spesso a senso unico, colma di una commovente identificazione del direttore con il suo compositore più amato, ricca di evidenti forzature ma anche di passaggi straordinari. Bernstein comincia a parlare di Mahler seduto al pianoforte in un caldo pomeriggio di maggio a Tel-Aviv; camicia completamente sbottonata su un torso sudato, aria da chi ha appena posato il bicchiere di whisky sul coperchio dello strumento. Ma poco dopo lo studio si trasferisce a Londra, in tutt’altro clima, e Lenny ora porta la stessa camicia, ma con sotto un dolcevita nero. Il piccolo tamburino del titolo e quello del Lied del Knaben Wunderhorn; il soldato-bambino che marcia verso la forca, disprezzato dai commilitoni per un’inesplicata colpa. E la colpa diventa subito la chiave per capire il dolore radicato nella musica di Mahler; la colpa di essere ebrei, la colpa di sentire tale condizione come una colpa; la colpa della conversione. Pieno di bellissima musica, il video si guarda e si ascolta come un saggio di Bernstein su se stesso, sul suo rapporto con la musica, con le radici ebraiche, con la colpa dell’assimilazione (e Candide fa continuamente capolino) esattamente come un saggio su Mahler. Un’ambiguità radicata nel modo di fare musica di un artista indimenticabile.
6 Novembre 2007 § § permalink
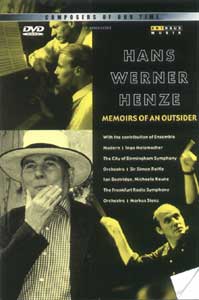
Devo ammettere la mia passione per i documentari. Quando il regista è una persona sensibile e intelligente, raramente li si guarda senza provare delle emozioni paragonabili a quelle che si provano con un buon film. Questo su Henze, parte di una riuscita collana di Arthaus Musik intitolata Composers of our time, mi è sembrato particolarmente bello. Henze si lascia intervistare parlando spesso per metafore, cercando parole che talvolta si ha l’impressione che non abbia più grande interesse a trovare, con quell’atteggiamento un po’ ludico e un po’ acido che spesso i compositori hanno dopo una certa età, quando non hanno più voglia di battaglie e polemiche ma si tolgono comunque qualche soddisfazione. La responsabilità più forte del compositore, dice a un certo punto, è quella di “costringere a essere creativi”; questa frase già da sola renderebbe, a mio avviso, preziosa la visione.
Il film, prodotto nel 2001 in occasione dei suoi 75 anni, è in buona parte girato nella sua splendida villa di Marino; così ordinata, ‘leccata’ verrebbe da dire, con il suo giardino in cui la natura non sembra avere più niente di misterioso, in cui tutto è così straordinariamente country, così intimamente borgese che quando gli si sente dire che nella sua vita molto è stato collegato all’“incertezza” verrebbe da non credergli. Ma sotto, per tutto il tempo, trascorre la sua musica, con una scelta oculatissima dei frammenti, in qualche caso davvero toccante. Come quando si parla dell’incontro con la Bachmann (o meglio, ancora una volta vi si allude), e per qualche decina di secondi si ascolta il primo Notturno di Nachtstücke und Arien, incredibilmente bello e misterioso. Allora anche l’idea dell’incertezza si chiarifica, e ogni stabilità si rende comprensibile come pacificazione a posteriori. In due brevi testimonianze appare anche Fausto Moroni, il compagno scomparso pochi mesi fa; anche in questo caso, una vaga sensazione di benessere familiare quasi borghese; ma ancora una volta è un’impressione che svanisce in una nebuloso senso di drammatica instabilità quotidiana.
Nel dvd compaiono Simon Rattle, Ingo Metzmacher, Oliver Knussen e molti altri, si ascolta splendida musica ed è compresa anche un’esecuzione integrale del Requiem (1990−93). Ma soprattutto si pensa alla musica, al suo passato e al suo presente; e non è poco.
20 Ottobre 2007 § § permalink
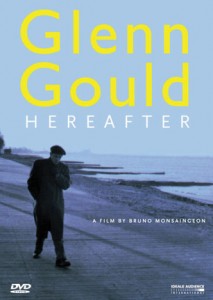 Forse qualcuno poteva pensare che Bruno Monsaingeon avesse già detto tutto su Glenn Gould, dopo quattro libri e sei o sette film. Eppure Glenn Gould Hereafter è un grande piacere per gli occhi e la mente. Qui spezzoni editi e inediti di “girato” con Gould come protagonista (ce ne sono centiaia di ore molte delle quali mai viste se non all’epoca) si alternano a episodi che riguardano la posterità di un artista così particolare. Sei personaggi, fra cui una simpatica signora bolognese, raccontano il loro rapporto con Gould, la nascita della loro passione e il peculiare modo attraverso cui si esprime. La giovane pianista che si è fatta tatuare il tema del quartetto di Gould sulla schiena, l’anziana signora russa il cui ultimo scopo di vita è “gouldianizzare” il mondo, il giovane giapponese che recapita le lettere con destinatari giapponesi che Gould ha scritto e mai spedito, e altri ancora. Poteva derivarne un atto di adorazione stucchevole, un prodotto confezionato per i tanti maniaci del pianista-mito, e invece Monsaingeon riesce a costruire un film intelligente, ricco e commovente.
Forse qualcuno poteva pensare che Bruno Monsaingeon avesse già detto tutto su Glenn Gould, dopo quattro libri e sei o sette film. Eppure Glenn Gould Hereafter è un grande piacere per gli occhi e la mente. Qui spezzoni editi e inediti di “girato” con Gould come protagonista (ce ne sono centiaia di ore molte delle quali mai viste se non all’epoca) si alternano a episodi che riguardano la posterità di un artista così particolare. Sei personaggi, fra cui una simpatica signora bolognese, raccontano il loro rapporto con Gould, la nascita della loro passione e il peculiare modo attraverso cui si esprime. La giovane pianista che si è fatta tatuare il tema del quartetto di Gould sulla schiena, l’anziana signora russa il cui ultimo scopo di vita è “gouldianizzare” il mondo, il giovane giapponese che recapita le lettere con destinatari giapponesi che Gould ha scritto e mai spedito, e altri ancora. Poteva derivarne un atto di adorazione stucchevole, un prodotto confezionato per i tanti maniaci del pianista-mito, e invece Monsaingeon riesce a costruire un film intelligente, ricco e commovente.
Il tema di fondo è quello dell’eredità, del retaggio che Gould ha lasciato alla posterità, della prodigiosa capacità epidemica che i virus di un artista di questo valore mantengono nel tempo. Dopo la visione rimangono nelle mente due considerazioni, fra le tante che il film solleva. La prima è che un artista che decide di presentare una precisa immagine di sé al mondo crea una più o meno grande barriera fatta di immagini, suoni e parole che ci danno la sensazione di conoscere, quasi di possedere interamente la sua anima. Ma guardandole molto da vicino, collazionandole con attenzione ci si accorge del trucco, del fatto che tutto è proiettato su uno schermo, e che fra questo schermo e l’artista sussiste un vuoto incolmabile. Così nasce il mistero, e così nascono le forme maniacali attraverso cui si cerca di colmarlo. Non diversamente che in amore, forse. La seconda è che effettivamente Gould ha rappresentato un tipo di artista con cui non smettiamo di dover fare i conti. Una delle scene più belle del film è uno dei famosi incontri fra Gould e Menuhin; i due artisti discutono della preminenza del concerto dal vivo o della registrazione in studio nella percezione musicale del futuro. La distanza che li divide è grande: due mondi le cui massime espressioni si sfiorano senza capirsi. Menuhin sopravviverà a Gould per quasi diciassette anni, la sua eredità artistica rimarrà per sempre altissima, tra le massime del Novecento; ma il retaggio umano, artistico e intellettuale di Gould giganteggia, superando il confine del secolo in cui è nato e disseminando il presente di quei molti dubbi e inquietudini che solo la grande arte sa (e forse deve) trasmettere.
J.S. Bach, Gavotta dalla Suite francese n. 6 (1971)
gavotte