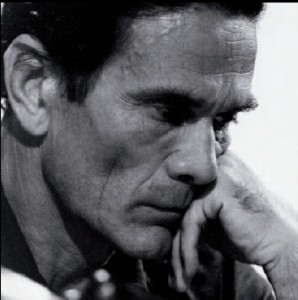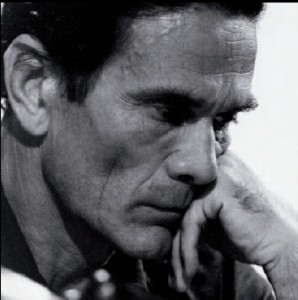
L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è, ora, il fascismo. Essere laici, liberali, non significa nulla, quando manca quella forza morale che riesca a vincere la tentazione di essere partecipi a un mondo che apparentemente funziona, con le sue leggi allettanti e crudeli. Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole: occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società.
Ho visto Pasolini. Un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, e letto il romanzo-inchiesta pubblicato da Mondadori con lo stesso titolo; mi sono sembrati entrambi molto interessanti e al tempo stesso piuttosto deboli – anche se sono riusciti nell’intento di fare brevemente riaprire l’ormai impossibile inchiesta. Mi sono sembrati deboli perché indagano i fatti, come sempre è successo per questo delitto, sotto l’abbagliante cono di luce della personalità e dell’opera di Pasolini. Non credo sia un’operazione sbagliata nelle premesse – come si potrebbe, d’altro canto, isolare i fatti da quel contesto umano, politico e culturale di cui Pasolini era un protagonista di primissimo piano? Credo tuttavia che sia un’operazione destinata inevitabilmente al fallimento: troppo forte la tentazione di trovare una giustificazione e una predestinazione nelle parole di un poeta lucidissimo (non è affatto un ossimoro) e di un intellettuale violentemente determinato a indicare le tante vie e i tanti responsabili del disfacimento della società italiana. E cercare una predestinazione significa anche attenuare il senso di una perdita incolmabile e assurda, proprio nel momento in cui si manifesta la sua profondità e assurdità.
Il film contiene alcuni brani molto belli tratti dagli scritti e le poesie di Pasolini, e così mi è tornato in mente il frammento sopra riportato, tratto dalla risposta che egli scrisse a due lettori del settimanale comunista “Vie nuove”. Era il 6 settembre 1962, e da due anni teneva una rubrica intitolata “Dialoghi con Pasolini”; “Vie nuove”, fondato nel 1946, era un periodico politico di taglio ‘popolare’, che si rivolgeva in particolare ai più giovani. In una lettera, due lettori torinesi gli avevano domandato perché secondo lui l’idea fascista esercitasse tanto fascino sui giovani, e Pasolini aveva risposto raccontando un aneddoto. Poco tempo prima aveva concesso un’intervista a una giornalista colta, determinata e di impostazione laica e liberale (oggi probabilmente si direbbe ‘di sinistra’). Erano andati insieme a Ostia, avevano parlato come amici, fatto il bagno insieme. Pasolini le aveva parlato apertamente di sé, e aveva amichevolmente ascoltato le confidenze che la donna gli aveva fatto. Lei aveva un figlio neofascista, con cui quotidianamente lottava e discuteva; era la sua spina nel fianco, il suo dolore. Al termine dell’intervista si erano salutati in amicizia, come persone accomunate da una ricerca ideale. Qualche settimana dopo, era uscito l’articolo: offensivo, indegno, colmo dei pregiudizi sulla sua persona che Pasolini detestava e a cui da sempre si ribellava. Tanto più indegno in quanto scritto da una persona che aveva gli strumenti per capire, e per fermare lo scempio. In conseguenza di questo, si chiedeva in che cosa consistesse il fascismo del presente, ed ecco arrivare questo passaggio straordinario e profondissimo.
Basta guardarsi attorno per vedere quanto fosse lucida questa visione. Il “benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo”. L’articolo si chiudeva con una sorta di maledizione biblica, che forse si è nel tempo trasformata in mera premonizione. Il figlio fascista era la conseguenza e il ‘contrappasso’ del fascismo mascherato della madre, del suo prestarsi a “contribuire a questa marcescenza”. L’anatema è divertente e doloroso, con quell’eco da tragedia greca; divertente perché vagamente ironico, terribile perché offre a noi nipoti una desolante spiegazione della realtà durissima da cui siamo assediati, interiormente ed esteriormente: “Che vi vengano figli fascisti – questa la nuova maledizione – figli fascisti, che vi distruggano con le idee nate dalle vostre idee, l’odio nato dal vostro odio”.
Ancora una volta la bellissima foto non so di chi sia. Lo scoprirò, promesso. Il brano è tratto da quella miniera inesauribile di idee, stimoli e grande scrittura civile che è il “Meridiano” di Pasolini Saggi sulla politica e sulla società (Mondadori, 1999; la risposta alla lettera si trova alle pp. 1014–18).

La vitalità di una forma artistica può essere giudicata anche attraverso la capacità di comunicare che i suoi codici simbolici conservano nel tempo. Curiosamente l’opera lirica, mille volte data per defunta e considerata alla stregua di una forma di assistenzialismo artistico persino da qualche ministro della cultura, continua a rivelarsi capace di comunicare concetti ed emozioni in una tale molteplicità di contesti da stupire anche il più appassionato dei suoi spettatori-ascoltatori.
In questi giorni è nei cinema italiani un bellissimo film del regista inglese Danny Boyle: The Millionaire (Slumdog Millionaire nella versione originale). È la storia di Jamal Malik, un ragazzo degli slum di Mumbai, e della sua lotta per sottrarsi al destino di miseria al quale sembra condannato per nascita e condizione; una lotta che è scandita dai tempi di due vicende parallele e intrecciate: la ricerca del riscatto economico attraverso la partecipazione al quiz televisivo Chi vuol esser milionario, e la disperata lotta per riavere Malika, la donna che ama fin da bambino, fin dal giorno in cui ha perso la madre, uccisa dal fanatismo religioso. Gli sta a fianco, alternativamente come spalla e antagonista, il fratello maggiore Salim, un ragazzo più violento e determinato, corresponsabile al tempo stesso del dolore e del successo di Jamal.

È un film molto ben costruito, che gioca con diversi codici simbolici e diversi ritmi: il mondo della televisione con i suoi format universali e il suo pathos, il cinema commerciale indiano con le sue convenzioni, i suoi miti e i suoi ritmi, in una girandola di fili narrativi intrecciati e salti temporali, di rimandi e allusioni che lo rende a volte persino eccessivamente “ripieno”. Ma c’è una scena che colpisce la retina e rimane misteriosamente registrata nella memoria, con tutti i significati e i simboli che porta con sé.
Jamal, Salim e Malika, i due moschettieri più uno (come si definiscono per gioco), si trovano a un certo punto del film a dover scappare da una banda di criminali che sfruttano i bambini degli slum costringendoli a chiedere l’elemosina per le strade di Mumbai; i due fratelli riescono a salire su un treno in corsa, ma Malika viene catturata. Scesi avventurosamente dal treno in quella che si scoprirà essere la città di Agra, davanti agli occhi di Jamal e Selim si dispiega improvvisamente la visione del Taj Mahal; una bellezza assurda, si potrebbe dire “fuori scala”, vista la durezza delle scene precedenti. I due bambini cominciano a vivere di espedienti attorno alle attrazioni del luogo, derubando i turisti o rivendendo le scarpe lasciate dai visitatori all’ingresso del palazzo. In seguito a uno di questi furti, Jamal viene duramente picchiato, e mentre si sta lavando le ferite nell’acqua di un fiume, sente una musica strana venire dai giardini del palazzo: noi lo sappiamo, è il suono di un oboe accompagnato dagli archi; lui comincia comincia a seguirlo, e arriva in un luogo che dato il contesto sembra quasi surreale: nei giardini si sta rappresentando uno spettacolo d’opera all’aperto, fra le luci dei riflettori e le scenografie. Mentre i suoi amici si arrampicano sui tralicci delle gradinate per rubare le borse degli spettatori, lui si sofferma a guardare.

Quella che si vede è una grande scena infernale, coperta di fuoco e solcata da rivoli incandescenti, con due persone al centro, un uomo e una donna: lei sembra morta, lui la abbraccia. Ma ciò che colpisce è quello che si sente: terminato il passaggio dell’oboe, l’uomo comincia a cantare, e le parole che intona sono di quelle che chi ama l’opera conosce molto bene: “Eurydice, Eurydice! Mortel silence! Vaine espérance! Quelle souffrance!”. È l’aria di Orfeo dal II atto dell’Orphée et Eurydice di Gluck, la famosa “J’ai perdu mon Eurydice”; l’oboe, anche se i titoli di coda non lo indicano, proviene da un’altra pagina meravigliosa, l’arioso “Quel nouveau ciel”.
Ecco la melodia dell’oboe:
arioso_gluck
ed ecco l’aria; la parte che si sente nel film è da 2:16
jai-perdu-mon-eurydice
Due tra i passaggi più patetici e profondi dell’opera, incollati con molta astuzia. L’inquadratura passa dal primo piano del viso pesto e incantato di Jamal a un flashback sul momento della separazione da Malika, il treno che corre, lei immobile che si fa sempre più lontana, e poi ancora lei, più grande, molto tempo dopo, che sorride alla stazione, in quel gioco di rimandi temporali incrociati che è una delle cose più belle di questo film.

Ecco che attraverso pochi secondi di musica, Boyle fornisce una chiave interpretativa molto forte, e lo fa utilizzando il codice simbolico del melodramma. Il desiderio, il dolore e l’ostinazione di Orfeo, che per riavere Euridice attraversa la palude infernale, sono quelli di Jamal; il suo canto, la sua prova di bravura, il gesto con cui commuove il mondo è la partecipazione a un quiz televisivo. Ma l’aria di Orfeo non è solo di dolore: contiene il senso di colpa. Orfeo piange perché la sua curiosità gli ha fatto perdere di nuovo Euridice; doveva tenere gli occhi chiusi, non doveva guardare, doveva fidarsi. Jamal è fuggito dai criminali che lo stavano per accecare; ha voluto sottrarsi a un destino segnato per sempre, ha voluto conoscere la vita, passare attraverso l’inferno del mondo per riconquistare davvero la libertà di Malika e la propria. Il significato che poche note musicali sanno portare è centrale per la comprensione del film, e curiosamente viene utilizzata un’opera del diciottesimo secolo; qualcosa di apparentemente lontanissimo dall’ambientazione della vicenda. Ma volendo guardare, c’è anche di più.
Che il codice dell’opera barocca non sia in realtà poi così lontano da quello del cinema di Bollywood, è cosa che più di un regista ci ha fatto scoprire da tempo (vedi per esempio il famoso Giulio Cesare di David McVicar). Ma anche senza abbandonarsi all’accanimento interpretativo, c’è un altro filo, chissà se del tutto casuale, che la presenza dell’aria di Gluck in quella scena porta con sé. Jamal fugge per evitare una mutilazione dettata da esigenze estetiche, pur se criminali: il canto di un bambino cieco attira dieci volte di più elemosine, dice uno dei personaggi. Gluck ha scritto quella melodia per Gaetano Guadagni, un castrato; la versione del film, tuttavia, è quella parigina per tenore… Chissà se Boyle ci ha pensato. La distanza tra le cose spesso è una questione di punti di vista; a volte sembra incredibile, ma l’opera sa ancora offrirne uno centrale e privilegiato rispetto a buona parte del nostro immaginario.
Le immagini sono tutte fotogrammi del film. I due brani musicali sono tratti dall’edizione dell’Orphée et Eurydice di C.W. Gluck utilizzata anche da Boyle per la colonna sonora. Si tratta dell’esecuzione diretta da Hans Rosbaud, con Leopold Simoneau, Suzanne Danco e l’Orchestre des Concerts Lamoureux (Philips 1956). La versione dell’opera è quella di Parigi del 1774, con Orfeo interpretato da un tenore (e Simoneau nella parte è una vera lezione di stile e fraseggio, anche se lontana anni luce dalle versioni filologiche di oggi).
Una bella favola romantica, un po’ melensa ma comunque commovente; proprio come dev’essere una favola. Si intitola The Violin, ed è un cortometraggio del 1974 di George Pastic da una storia sua e di George Welsh (nel 1977 ne fu ricavato anche un libro). Nel 1974 fu candidata all’Oscar. Il filmato è stato reso disponibile in rete da Michael Monroe sul suo blog MMmusing (grazie!). Il vecchio violinista è il canadese Maurice Solway, che ha anche curato la colonna sonora; non uno qualunque, ma un allievo di Eugène Ysaÿe. Certo, lo si può buttare come una roba sdolcinata e ingenua, ma assicuro che, pur nel linguaggio delle favole, in chi da piccolo ha studiato il violino (ma forse qualsiasi strumento), questo film qualche richiamo sentimentale e persino profondo lo suscita; riguarda il fascino dello strumento, il potere ipnotico della musica, il desiderio di emulazione e la figura dell’insegnante. Ma ognuno lo veda come gli pare.