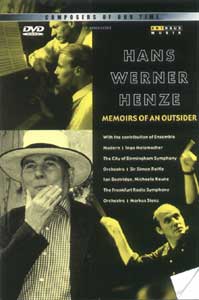Quali sono stati i libri di argomento musicale più importanti del 2007? I giornali di tutto il mondo non lasciano molti dubbi, e mettono al primo posto, con una rassegna stampa imponente, The Rest is Noise, di Alex Ross. Uscito lo scorso ottobre negli Stati Uniti per Farrar, Straus and Giroux, il libro, che riporta il sottotitolo Listening to the Twentieth Century, è una bellissima storia della musica del Novecento condotta con taglio narrativo, piglio sicuro e grande capacità affabulatoria da un giovane critico newyorkese, che negli ultimi dieci anni si è segnalato come uno dei più sensibili cronisti e intenditori del rapporto tra musica e linguaggi contemporanei. Ross scrive sul New Yorker, una delle migliori riviste dell’intelligentsija americana, ma è anche più conosciuto, al di là di ogni confine geografico, per il suo influente blog che porta lo stesso titolo del libro. Lì ha cominciato, da ormai moltissimi mesi, ad annunciare il suo volume; da lì ha diffuso le sue recensioni, segnalazioni e analisi in tutto il mondo. Circa 600 pagine, suddivise in tre parti per quindici capitoli complessivi, su questo libro, che in italiano sarà pubblicato da Bompiani, torneremo presto. Basti dire che, anche senza prestare acriticamente fede alle tante recensioni encomiastiche che ha ricevuto, si caratterizza fin dalla prima, rapsodica lettura per la forza con cui tira le fila di un secolo di musica e lo immerge in una visione storica fatta di equilibrate sicurezze.
Quali sono stati i libri di argomento musicale più importanti del 2007? I giornali di tutto il mondo non lasciano molti dubbi, e mettono al primo posto, con una rassegna stampa imponente, The Rest is Noise, di Alex Ross. Uscito lo scorso ottobre negli Stati Uniti per Farrar, Straus and Giroux, il libro, che riporta il sottotitolo Listening to the Twentieth Century, è una bellissima storia della musica del Novecento condotta con taglio narrativo, piglio sicuro e grande capacità affabulatoria da un giovane critico newyorkese, che negli ultimi dieci anni si è segnalato come uno dei più sensibili cronisti e intenditori del rapporto tra musica e linguaggi contemporanei. Ross scrive sul New Yorker, una delle migliori riviste dell’intelligentsija americana, ma è anche più conosciuto, al di là di ogni confine geografico, per il suo influente blog che porta lo stesso titolo del libro. Lì ha cominciato, da ormai moltissimi mesi, ad annunciare il suo volume; da lì ha diffuso le sue recensioni, segnalazioni e analisi in tutto il mondo. Circa 600 pagine, suddivise in tre parti per quindici capitoli complessivi, su questo libro, che in italiano sarà pubblicato da Bompiani, torneremo presto. Basti dire che, anche senza prestare acriticamente fede alle tante recensioni encomiastiche che ha ricevuto, si caratterizza fin dalla prima, rapsodica lettura per la forza con cui tira le fila di un secolo di musica e lo immerge in una visione storica fatta di equilibrate sicurezze.
Accanto al libro di Ross, fra i più segnalati da tutti i giornali c’è il nuovo studio di Oliver Sacks, dedicato al rapporto tra musica e cervello umano: Musicophilia: Tales of Music and the Brain, pubblicato da Knopf, imprint del gigante Random Hause. Un altro bellissimo libro, di argomento molto vicino, è quello di Daniel Livitin: This is Your Brain in Music: Understanding a Human Obsession, pubblicato da Atlantic. Questi ultimi due testi sembrerebbero far pensare a un ritorno di interesse su un tema da molti anni trascurato dalla musicologia, e cioè quello della fisiologia e della neurologia dell’ascolto. Ma il fatto che vengano pubblicati da editori non specializzati in musica, e siano stati recensiti da giornali generalmente disattenti alla materia dispone ad altre riflessioni.
Si tratta davvero dei tre libri più importanti dell’anno? Molto probabilmente no, se li si analizza da un punto di vista strettamente musicologico. Ma ciò che più preme far notare è che si tratta di tre libri che hanno la forza di riportare la musica al centro del dibattito storico e scientifico, facendola uscire dalla nicchia dei musicofili e dei musicologi. E non è poco, se si pensa agli effetti che questo spesso superbo isolamento sta causando alla più ardua e necessaria tra le espressioni della creatività umana. Torneremo al più presto su ognuno di essi.
I libri che forse dovremmo leggere
19 Dicembre 2007 § 0 commenti § permalink
Stelle, strisce e musica a Pyongyang
11 Dicembre 2007 § 0 commenti § permalink
Dunque la New York Philharmonic terrà un concerto a Pyongyang. Dopo lunghe trattative, la dirigenza dell’orchestra ha reso ufficiale che il governo coreano ha accettato tutte le condizioni; la data dovrebbe essere il 26 febbraio 2008. Zarin Mehta, il presidente dell’orchestra, non ha voluto rivelare molti particolari ai giornalisti, rimandando alla conferenza stampa ufficiale; però ha spiegato quali fossero le principali condizioni poste dall’orchestra al governo coreano: alcune sono comprensibili, altre encomiabili, ma una, in particolare, lascia interdetti.
La prima e più ovvia delle condizioni è quella che riguarda la sicurezza degli orchestrali, e in particolare di quelli di origine coreana. E qui siamo d’accordo. Altre condizioni riguardano aspetti vicini al diritto d’informazione: la presenza di giornalisti locali e stranieri, e la trasmissione in diretta del concerto sulle emittenti nazionali, per evitare di far diventare la serata una passerella per il regime. Encomiabile. Altre condizioni riguardavano gli aspetti pratici e organizzativi: l’impegno a migliorare l’acustica della sala (l’East Pyongyang Grand Theater), la delicatissima questione del trasporto degli strumenti e così via. Ma la richiesta che spicca è quella che riguarda la possibilità, da parte dell’orchestra, di aprire il concerto con l’inno nazionale americano, “The Star-Spangled Banner”.
Che il concerto sia una questione più diplomatica che artistica è sicuro. Come informano tutti i giornali americani, la trattativa è stata seguita con interesse dal Dipartimento di Stato, e commentata molto positivamente alla luce delle recenti aperture di Bush nei confronti del governo di Kim-Jong-il (finora inchiodato saldamente all’asse del male). I paragoni si sprecano: i concerti della Boston Symphony in Unione Sovietica nel 1956, seguiti nel ’59 da quelli della stessa NYP, diretta da Bernstein. O nel 1973, subito dopo la visita di Nixon in Cina, i concerti a Pechino della Philadelphia Orchestra. La capacità della musica di varcare le frontiere e di abbattere le barriere fra i popoli è uno dei luoghi comuni più ricorrenti nel jet-set musicale mondiale. Non certo falso, come tutti i luoghi comuni; solo, diciamo così, facilmente incline all’ipocrisia.
Bernstein era ben conscio del portato politico di un concerto di una delle grandi orchestre americane nel cuore della dittatura sovietica; sicuramente nella NYP c’erano più rifugiati russi (o loro affini) di quanti ce ne siano oggi di coreani. Parlava di Šostakovič nelle conferenze stampa, lo eseguiva, inseriva l’opera di un compositore americano in ogni concerto. Era uno scambio, un segnale, bello e importante. I concerti si aprivano con l’orchestra che intonava l’inno sovietico; il pubblico si alzava in piedi, e ci rimaneva durante l’inno americano. Uno scambio, appunto. Furono molti i commentatori che, anche allora, parlarono di sostegno alla dittatura, di legittimazione eccetera. Eppure non furono necessari particolari sovrattoni patriottici.
Oggi la condizione di aprire il concerto con “The Star-Spangled Banner” sembra quasi uno schiaffo. Perché questa richiesta, se davvero si ritiene che la musica abbia la forza di superare i conflitti e le lacerazioni della politica. Ma davvero, poi, lo si ritiene?
AGGIUNTA DEL 7 MARZO 2008
In realtà Maazel ha diretto “The Star-Spangled Banner” dopo l’inno nordcoreano. In compenso il programma scelto per la serata aveva un aspetto curiosamente elementare nella sua programmaticità, con la Sinfonia “dal Nuovo Mondo” di Dvorák e Un americano a Parigi di Gershwin. Un buon resoconto del concerto, con le sue luci e le sue ombre, può essere letto in questo articolo dell’Economist.
Dudamel e la bacchetta magica
6 Dicembre 2007 § 0 commenti § permalink
Per il suo debutto con la New York Philharmonic, Gustavo Dudamel ha ricevuto dalle mani di Barbara Haws, storica e conservatrice dell’orchestra, una delle tre preziosissime bacchette utilizzate da Leonard Bernstein. Questo per capire quale assurda aspettativa si sia creata intorno al giovane direttore venezuelano. La bacchetta del mago; una cosa più alla Harry Potter che alla Dukas. Dudamel l’ha usata per tutte e quattro le serate alla Avery Fisher Hall; in programma, la “Sinfonia India” di Chávez (pezzo eseguito con la NYP da Bernstein nel 1961), il Concerto per violino di Dvorák con Gil Shaham e la Quinta di Prokof’ev. Il «New York Times» ci avverte che alla quarta sera, martedì scorso, poco prima della fine, la bacchetta di Bernstein s’è rotta. Niente di personale, si dice.
Meditazioni amorose
29 Novembre 2007 § 1 commento § permalink
Lorraine Hunt è stata una splendida mezzosoprano, amata dal pubblico della musica barocca per le sue tante interpretazioni di Händel e Monteverdi con Christie, McGegan, Jacobs e altri; nel 1999 aveva sposato il compositore Peter Lieberson, cominciando a dedicarsi anche alla musica contemporanea e dando voce a molti compositori delle ultime generazioni. La ricorda ora un disco molto bello, che raccoglie cinque sonetti di Pablo Neruda tratti dai Cien sonetos de amor (1959), musicati e a lei dedicati da Lieberson. Lo stile è decisamente eclettico, con brevi puntate nella popular e un solido vocabolario post e neoromantico; ma la caratteristica che più colpisce di questi cinque brani, al di là di qualsiasi considerazione stilistica, è la profonda sensualità da cui sono pervasi. Trascinato dai testi di Neruda, Lieberson costruisce una meditazione su amore e morte, sulla gioia attonita del possesso e sulla paura della perdita. I Neruda Songs sono il risultato di una commissione della Los Angeles Philarmonic, e sono stati registrati da James Levine con la Boston Symphony Orchestra nel 2005, dal vivo. Meno di un anno dopo Lorraine Hunt Lieberson, come volle firmarsi dopo il matrimonio, è scomparsa per le complicanze di un cancro al seno. Al momento della registrazione lottava da tempo contro la malattia, eppure non c’è ombra di esagerazione o affettazione dolorosa nel suo canto: pensoso e appassionato, lo si direbbe invece. Anche quando il testo si fa fortemente drammatico, rimane quel distacco che i versi neobarocchi di Neruda consentono; versi bellissimi, come questi del sonetto XCII, intitolato Amor mío, si muero y tú no mueres (Amore mio, se io muoio e tu non muori):
Pero este amor, amor, no ha terminado,
y así como no tuvo nacimiento
no tiene muerte, es como un largo río,
sólo cambia de tierras y de labios.(Però questo amore, amore, non è finito: | e così come non ha avuto nascita | non conosce la morte e, come un lungo fiume, | cambia solo di terra e di labbra).
Nella foto, Lorraine Hunt Lieberson fotografata nel 2003 da Richard Avendon (per il «New Yorker»).
P. Lieberson, Ya eres mia. Reposa con tu sueño en mi sueño (Ormai sei mia. Riposa col tuo sonno nel mio sonno), ms. L.H. Lieberson, Boston Symphony Orchestra, dir. James Levine (2005)
Musica ai limiti dell’umano
26 Novembre 2007 § 0 commenti § permalink
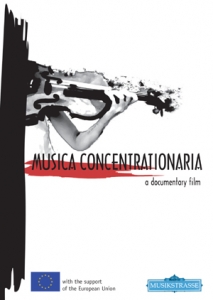 È molto difficile interrogarsi sul significato che la musica può avere per la vita di un uomo quando una tappezzeria sonora riveste interamente le nostre giornate; così come appare sempre più raro riuscire a coltivare quel particolare silenzio interiore che l’ascolto richiede; capita di arrivare trafelati al concerto di un grande artista, e aspettare invano che il turbine della sua grande ala ci sfiori. Assuefatti e rintronati dall’onnipresenza della musica. Ma ascoltare il racconto di chi ha vissuto l’esperienza musicale al limite dell’esperienza umana fa tornare in mente alcuni valori fondamentali, sopiti da quella che potrebbe essere definita “sovrastimolazione estetica”. Musica Concentrationaria è uno strano documentario, nato come parte di un ambiziosissimo progetto condotto dal musicista pugliese Francesco Lotoro: raccogliere tutta la documentazione relativa alla musica composta in prigionia lungo l’intero arco del Ventesimo Secolo, sotto ogni latitudine, e registrarla poi in una sontuosa collana di dischi (24 cd, per la Musikstrasse). In questo DVD sono raccolte una ventina di interviste a sopravvissuti ai campi di prigionia o di concentramento europei, o a loro parenti stretti, e viene documentata la terribile situazione di chi vede dipendere la propria sopravvivenza materiale o anche solo spirituale dall’emozione o dal mestiere del fare musica. Chi ha fatto musica per provare un estremo barlume di libertà o di comunità spirituale, per superare la solitudine e la disperazione di una detenzione inumana e selvaggia, di una condanna a un lavoro stremante e senza speranza; o chi ha dovuto fare musica per allietare i propri aguzzini. Fra questi due poli, l’enorme varietà di esperienze che la musica rende possibili anche “al di fuori” della civiltà da cui si vorrebbe creata. Il DVD ha una regia piuttosto sommaria, fatta con un materiale di base costituito da pochi piani sequenza e tante interviste a camera quasi fissa; eppure, qua e là, momenti di grande emozione. E poi quei visi. I visi di chi ha visto; di chi vorrebbe che non fosse scordato, di chi ha passato un’intera vita a elaborare, e vorrebbe aiutarci a non dovere un giorno ripartire da zero. Prima e ultima testimonianza, quella della grande clavicembalista ceca Zuzana Ruzickova, deportata nel 1941 nel cosiddetto “ghetto di Terezín” (Teresienstadt). Sullo sfondo, la storia incredibile di alcuni grandi compositori che continuarono a fare musica, spesso con straordinario impegno e con importanti risultati, anche quando per loro tutto era perduto, quando persino la fiducia nell’essere umano non poteva che essere svanita: Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, e tanti altri minori, fino ai minimi, a coloro che sapevano solo cantare una canzone, e magari lo facevano in cambio di tre minuti di sospensione del lavoro. Da non dimenticare. Assolutamente, per il bene di tutti.
È molto difficile interrogarsi sul significato che la musica può avere per la vita di un uomo quando una tappezzeria sonora riveste interamente le nostre giornate; così come appare sempre più raro riuscire a coltivare quel particolare silenzio interiore che l’ascolto richiede; capita di arrivare trafelati al concerto di un grande artista, e aspettare invano che il turbine della sua grande ala ci sfiori. Assuefatti e rintronati dall’onnipresenza della musica. Ma ascoltare il racconto di chi ha vissuto l’esperienza musicale al limite dell’esperienza umana fa tornare in mente alcuni valori fondamentali, sopiti da quella che potrebbe essere definita “sovrastimolazione estetica”. Musica Concentrationaria è uno strano documentario, nato come parte di un ambiziosissimo progetto condotto dal musicista pugliese Francesco Lotoro: raccogliere tutta la documentazione relativa alla musica composta in prigionia lungo l’intero arco del Ventesimo Secolo, sotto ogni latitudine, e registrarla poi in una sontuosa collana di dischi (24 cd, per la Musikstrasse). In questo DVD sono raccolte una ventina di interviste a sopravvissuti ai campi di prigionia o di concentramento europei, o a loro parenti stretti, e viene documentata la terribile situazione di chi vede dipendere la propria sopravvivenza materiale o anche solo spirituale dall’emozione o dal mestiere del fare musica. Chi ha fatto musica per provare un estremo barlume di libertà o di comunità spirituale, per superare la solitudine e la disperazione di una detenzione inumana e selvaggia, di una condanna a un lavoro stremante e senza speranza; o chi ha dovuto fare musica per allietare i propri aguzzini. Fra questi due poli, l’enorme varietà di esperienze che la musica rende possibili anche “al di fuori” della civiltà da cui si vorrebbe creata. Il DVD ha una regia piuttosto sommaria, fatta con un materiale di base costituito da pochi piani sequenza e tante interviste a camera quasi fissa; eppure, qua e là, momenti di grande emozione. E poi quei visi. I visi di chi ha visto; di chi vorrebbe che non fosse scordato, di chi ha passato un’intera vita a elaborare, e vorrebbe aiutarci a non dovere un giorno ripartire da zero. Prima e ultima testimonianza, quella della grande clavicembalista ceca Zuzana Ruzickova, deportata nel 1941 nel cosiddetto “ghetto di Terezín” (Teresienstadt). Sullo sfondo, la storia incredibile di alcuni grandi compositori che continuarono a fare musica, spesso con straordinario impegno e con importanti risultati, anche quando per loro tutto era perduto, quando persino la fiducia nell’essere umano non poteva che essere svanita: Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, e tanti altri minori, fino ai minimi, a coloro che sapevano solo cantare una canzone, e magari lo facevano in cambio di tre minuti di sospensione del lavoro. Da non dimenticare. Assolutamente, per il bene di tutti.
“Lenny” Mahler e il senso di colpa
16 Novembre 2007 § 0 commenti § permalink
A diciassette anni dalla sua scomparsa, Lenny Bernstein non finisce di rappresentare una gallina dalle uova d’oro per l’industria discografica e una fonte di scoperte e piaceri per gli appassionati di musica. La diffusione del DVD ha fatto sì che le sue centinaia (o migliaia?) di ore di registrazione video possano uscire poco alla volta, continuando a riservare delle sorprese al grande pubblico. L’ultima serie di DVD pubblicata dalla Deutsche Grammophon comprende, per esempio, una bella integrale delle Sinfonie di Brahms, un documentario sulla vita di Bernstein e questo curioso “saggio” video: The Little Drummer Boy: an Essay on Gustav Mahler. Girato nel 1984 a più riprese e in diversi luoghi, è una lunga lezione di Bernstein sulla componente ebraica nella musica e nella vita interiore di Mahler. Una lettura spesso a senso unico, colma di una commovente identificazione del direttore con il suo compositore più amato, ricca di evidenti forzature ma anche di passaggi straordinari. Bernstein comincia a parlare di Mahler seduto al pianoforte in un caldo pomeriggio di maggio a Tel-Aviv; camicia completamente sbottonata su un torso sudato, aria da chi ha appena posato il bicchiere di whisky sul coperchio dello strumento. Ma poco dopo lo studio si trasferisce a Londra, in tutt’altro clima, e Lenny ora porta la stessa camicia, ma con sotto un dolcevita nero. Il piccolo tamburino del titolo e quello del Lied del Knaben Wunderhorn; il soldato-bambino che marcia verso la forca, disprezzato dai commilitoni per un’inesplicata colpa. E la colpa diventa subito la chiave per capire il dolore radicato nella musica di Mahler; la colpa di essere ebrei, la colpa di sentire tale condizione come una colpa; la colpa della conversione. Pieno di bellissima musica, il video si guarda e si ascolta come un saggio di Bernstein su se stesso, sul suo rapporto con la musica, con le radici ebraiche, con la colpa dell’assimilazione (e Candide fa continuamente capolino) esattamente come un saggio su Mahler. Un’ambiguità radicata nel modo di fare musica di un artista indimenticabile.
Henze borghese e progressivo
6 Novembre 2007 § 0 commenti § permalink
Devo ammettere la mia passione per i documentari. Quando il regista è una persona sensibile e intelligente, raramente li si guarda senza provare delle emozioni paragonabili a quelle che si provano con un buon film. Questo su Henze, parte di una riuscita collana di Arthaus Musik intitolata Composers of our time, mi è sembrato particolarmente bello. Henze si lascia intervistare parlando spesso per metafore, cercando parole che talvolta si ha l’impressione che non abbia più grande interesse a trovare, con quell’atteggiamento un po’ ludico e un po’ acido che spesso i compositori hanno dopo una certa età, quando non hanno più voglia di battaglie e polemiche ma si tolgono comunque qualche soddisfazione. La responsabilità più forte del compositore, dice a un certo punto, è quella di “costringere a essere creativi”; questa frase già da sola renderebbe, a mio avviso, preziosa la visione.
Il film, prodotto nel 2001 in occasione dei suoi 75 anni, è in buona parte girato nella sua splendida villa di Marino; così ordinata, ‘leccata’ verrebbe da dire, con il suo giardino in cui la natura non sembra avere più niente di misterioso, in cui tutto è così straordinariamente country, così intimamente borgese che quando gli si sente dire che nella sua vita molto è stato collegato all’“incertezza” verrebbe da non credergli. Ma sotto, per tutto il tempo, trascorre la sua musica, con una scelta oculatissima dei frammenti, in qualche caso davvero toccante. Come quando si parla dell’incontro con la Bachmann (o meglio, ancora una volta vi si allude), e per qualche decina di secondi si ascolta il primo Notturno di Nachtstücke und Arien, incredibilmente bello e misterioso. Allora anche l’idea dell’incertezza si chiarifica, e ogni stabilità si rende comprensibile come pacificazione a posteriori. In due brevi testimonianze appare anche Fausto Moroni, il compagno scomparso pochi mesi fa; anche in questo caso, una vaga sensazione di benessere familiare quasi borghese; ma ancora una volta è un’impressione che svanisce in una nebuloso senso di drammatica instabilità quotidiana.
Nel dvd compaiono Simon Rattle, Ingo Metzmacher, Oliver Knussen e molti altri, si ascolta splendida musica ed è compresa anche un’esecuzione integrale del Requiem (1990−93). Ma soprattutto si pensa alla musica, al suo passato e al suo presente; e non è poco.
L’evo di Adams
30 Ottobre 2007 § 0 commenti § permalink
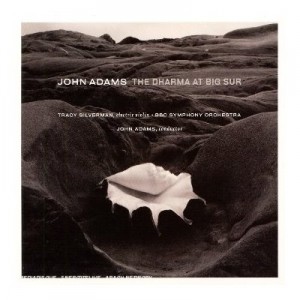 È strano come il concerto solistico, ben lungi dall’essere in qualche modo ridimensionato dalla fine di un mondo, quello del grande concertismo internazionale, continui a generare nei migliori compositori ispirazioni spesso più felici della musica per orchestra. Gli ultimi grandi divi-virtuosi si stanno spegnendo, nascono figure di volta in volta più “glamour” o più tecnicamente preparate, ma difficilmente si potrà ritrovare, almeno nel futuro prossimo, quel particolare carisma che il solista conquistava con l’appartenere a un mondo che aveva qualcosa da dire, che rappresentava qualcosa oltre a se stesso. Eppure di quel mondo si nutriva la forma stessa della musica: difficile pensare al ruolo, alla voce che il violino “porta” nel concerto di Brahms senza Joachim, o al violoncello di Sostakovic senza il rimpianto Rostropovich.
È strano come il concerto solistico, ben lungi dall’essere in qualche modo ridimensionato dalla fine di un mondo, quello del grande concertismo internazionale, continui a generare nei migliori compositori ispirazioni spesso più felici della musica per orchestra. Gli ultimi grandi divi-virtuosi si stanno spegnendo, nascono figure di volta in volta più “glamour” o più tecnicamente preparate, ma difficilmente si potrà ritrovare, almeno nel futuro prossimo, quel particolare carisma che il solista conquistava con l’appartenere a un mondo che aveva qualcosa da dire, che rappresentava qualcosa oltre a se stesso. Eppure di quel mondo si nutriva la forma stessa della musica: difficile pensare al ruolo, alla voce che il violino “porta” nel concerto di Brahms senza Joachim, o al violoncello di Sostakovic senza il rimpianto Rostropovich.
Eppure il concerto solistico continua la sua strada, con dei momenti di altissima ispirazione. The Dharma at Big Sur è uno di essi. Scritto per l’eccezionale violino elettrico a cinque corde di Tracy Silberman, dimostra quanta strada continui a fare John Adams senza lasciarsi acciuffare dall’etichettatrice della critica, cercando, sperimentando e più di una volta trovando. Due movimenti per un totale di 27 minuti circa, organico ricco, forma complessa e colma di ricercatezze, tante citazioni e omaggi ma scarsissima propensione alla parodia. Un pezzo veramente bellissimo, che non ci si stanca di riascoltare, che non rifugge il pathos ma senza neoromanticismi. In Italia lo suona (e bene, dice chi lo ha ascoltato) Francesco D’Orazio.
Ora lo si può ascoltare in un prezioso doppio cd, accostato a un’altra e diversissima composizione recente di Adams, My Father knew Charles Ives. Un pezzo più riflessivo (si tenga conto del fatto che The Dharma at Big Sur era stato scritto per l’inaugurazione della Walt Disney Hall) ma sempre caratterizzato dalla stessa controllata estroversione; una voglia di comunicare senza svendere la propria personalità creativa. Ma al tempo stesso un altissimo controllo delle dinamiche, della strumentazione, dello stile. Più ricco del precedente di omaggi alla tradizione musicale americana (a Copland più di tutti), fitto di riferimenti autobiografici e familiari, con quella tendenza all’epicizzazione del privato che solo gli americani sanno avere (è per questo che amano tanto Mahler?). Tre movimenti per 26 minuti circa di musica; misterioso il motivo della ripartizione in due cd dei contenuti (naturalmente il costo è quello di un singolo). Una delle migliori cose che abbia ascoltato di recente.
L’eredità di Gould
20 Ottobre 2007 § 0 commenti § permalink
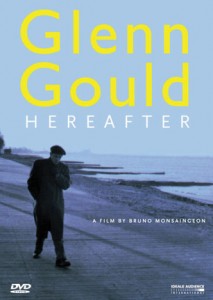 Forse qualcuno poteva pensare che Bruno Monsaingeon avesse già detto tutto su Glenn Gould, dopo quattro libri e sei o sette film. Eppure Glenn Gould Hereafter è un grande piacere per gli occhi e la mente. Qui spezzoni editi e inediti di “girato” con Gould come protagonista (ce ne sono centiaia di ore molte delle quali mai viste se non all’epoca) si alternano a episodi che riguardano la posterità di un artista così particolare. Sei personaggi, fra cui una simpatica signora bolognese, raccontano il loro rapporto con Gould, la nascita della loro passione e il peculiare modo attraverso cui si esprime. La giovane pianista che si è fatta tatuare il tema del quartetto di Gould sulla schiena, l’anziana signora russa il cui ultimo scopo di vita è “gouldianizzare” il mondo, il giovane giapponese che recapita le lettere con destinatari giapponesi che Gould ha scritto e mai spedito, e altri ancora. Poteva derivarne un atto di adorazione stucchevole, un prodotto confezionato per i tanti maniaci del pianista-mito, e invece Monsaingeon riesce a costruire un film intelligente, ricco e commovente.
Forse qualcuno poteva pensare che Bruno Monsaingeon avesse già detto tutto su Glenn Gould, dopo quattro libri e sei o sette film. Eppure Glenn Gould Hereafter è un grande piacere per gli occhi e la mente. Qui spezzoni editi e inediti di “girato” con Gould come protagonista (ce ne sono centiaia di ore molte delle quali mai viste se non all’epoca) si alternano a episodi che riguardano la posterità di un artista così particolare. Sei personaggi, fra cui una simpatica signora bolognese, raccontano il loro rapporto con Gould, la nascita della loro passione e il peculiare modo attraverso cui si esprime. La giovane pianista che si è fatta tatuare il tema del quartetto di Gould sulla schiena, l’anziana signora russa il cui ultimo scopo di vita è “gouldianizzare” il mondo, il giovane giapponese che recapita le lettere con destinatari giapponesi che Gould ha scritto e mai spedito, e altri ancora. Poteva derivarne un atto di adorazione stucchevole, un prodotto confezionato per i tanti maniaci del pianista-mito, e invece Monsaingeon riesce a costruire un film intelligente, ricco e commovente.
Il tema di fondo è quello dell’eredità, del retaggio che Gould ha lasciato alla posterità, della prodigiosa capacità epidemica che i virus di un artista di questo valore mantengono nel tempo. Dopo la visione rimangono nelle mente due considerazioni, fra le tante che il film solleva. La prima è che un artista che decide di presentare una precisa immagine di sé al mondo crea una più o meno grande barriera fatta di immagini, suoni e parole che ci danno la sensazione di conoscere, quasi di possedere interamente la sua anima. Ma guardandole molto da vicino, collazionandole con attenzione ci si accorge del trucco, del fatto che tutto è proiettato su uno schermo, e che fra questo schermo e l’artista sussiste un vuoto incolmabile. Così nasce il mistero, e così nascono le forme maniacali attraverso cui si cerca di colmarlo. Non diversamente che in amore, forse. La seconda è che effettivamente Gould ha rappresentato un tipo di artista con cui non smettiamo di dover fare i conti. Una delle scene più belle del film è uno dei famosi incontri fra Gould e Menuhin; i due artisti discutono della preminenza del concerto dal vivo o della registrazione in studio nella percezione musicale del futuro. La distanza che li divide è grande: due mondi le cui massime espressioni si sfiorano senza capirsi. Menuhin sopravviverà a Gould per quasi diciassette anni, la sua eredità artistica rimarrà per sempre altissima, tra le massime del Novecento; ma il retaggio umano, artistico e intellettuale di Gould giganteggia, superando il confine del secolo in cui è nato e disseminando il presente di quei molti dubbi e inquietudini che solo la grande arte sa (e forse deve) trasmettere.
J.S. Bach, Gavotta dalla Suite francese n. 6 (1971)
Lettere a Vermeer
18 Ottobre 2007 § 0 commenti § permalink
 Non capita molto spesso di ascoltare una nuova opera con la sensazione di trovarsi di fronte a un lavoro di grande felicità espressiva e ricchezza culturale. È però il caso di Writing to Vermeer, l’opera composta da Louis Andriessen negli anni 1997–98 su commissione di De Nederlandse Opera di Amsterdam, dove ha debuttato nel 1999. La si può ora ascoltare in un doppio cd, molto ben confezionato dalla Nonesuch.
Non capita molto spesso di ascoltare una nuova opera con la sensazione di trovarsi di fronte a un lavoro di grande felicità espressiva e ricchezza culturale. È però il caso di Writing to Vermeer, l’opera composta da Louis Andriessen negli anni 1997–98 su commissione di De Nederlandse Opera di Amsterdam, dove ha debuttato nel 1999. La si può ora ascoltare in un doppio cd, molto ben confezionato dalla Nonesuch.
L’opera si compone di sei scene, nelle quali si intersecano diverse linee di articolazione drammatica, psicologica, intellettuale e musicale. La base è un affascinante libretto di Peter Greeneway, sostanzialmente privo di azione drammatica ma al tempo stesso dotato di un particolare crescendo ansiogeno, amplificato con grande sapienza drammaturgica da Andriessen. Tra il 16 e il 26 maggio 1672, tre donne scrivono sei lettere ciascuna a Johannes Vermeer, momentaneamente lontando da Delft per un viaggio d’affari all’Aja; Catharina Bolnes, moglie del pittore, Maria Thins, la di lei madre, e un’immaginaria modella di nome Saskia de Vries raccontano a Veermer i piccoli fatti della vita domestica quotidiana – un progetto di matrimonio fallito e un altro di cui si gettano le basi per la giovane Saskia, la vita dei figli dell’artista – cercando di fargli sentire quanto a loro manchi la sua presenza, pregandolo continuamente di tornare al più presto. Come sempre accade nei lavori in cui è coinvolto Greenaway, la trama procede per allusioni più o meno criptiche a fatti e circostanze che si riescono solo a immaginare in filigrana; per esempio la presenza di cinque fluidi che minacciano la serenità domestica della famiglia: la vernice, che un mattino la piccola Cornelia mangia per gioco, il latte, che continuamente viene versato, il sangue, che simbolizza l’assassinio e la violenza, e infine l’acqua, che negli ultimi secondi dell’opera sommergerà la scena.
Cinque elementi che rappresentano nella loro quotidianità la sotterranea minaccia che il mondo esterno, la storia e l’attualità recano all’apparentemente serena vita della famiglia Vermeer. La storia d’altro canto fa irruzione nell’opera anche attraverso dieci inserti sonori sapientemente incastonati nel dipanarsi del libretto, nei quali essa agisce come in un fondale che lentamente e pericolosamente si avvicina alla scena familiare fino a sommergerla nel finale. Si tratta di dieci momenti della cruenta storia olandese di quei giorni: la dura opposizione tra cattolici e protestanti, un’esplosione a Delft, il crollo del mercato dei tulipani, l’orribile assassinio di due diplomatici olandesi, l’invasione francese, fino all’inondazione con cui gli olandesi si difendono dai francesi, principale causa della rovina di Vermeer secondo i documenti storici. Questi inserti sono realizzati attraverso il live electronic di Michel vad der Aa, che compone cellule melodiche a suoni fortemente relistici: campane da chiesa, esplosioni, respiri affannosi, scrosci d’acqua, urla, passi.
La musica è altrettanto ricca di suggestioni, citazioni rimandi, ma cucita in un tessuto di grande coerenza e fascino; i nomi che vengono in mente o che Andriessen stesso cita nelle note di copertina del disco sono quelli di John Cage per le scelte strutturali e per diverse sonorità, ma anche Steve Reich in alcuni trattamenti delle tastiere, perfino Webern in alcuni momenti di forte rarefazione timbrica e melodica. Il suono combina in maniera davvero brillante la modernità estrema e le sonorità barocche delle esecuzioni filologiche, senza soluzione di continuità e in bellissimo trascolorare da una tavolozza all’altra; la vocalità ricorda talvolta Britten, ma è sempre molto naturale e sciolta. L’orchestra comprende un gruppo di archi inconsuetamente corposo per Andriessen (12 violini, 8 fra viole e violoncelli, due contabbassi), legni, ottoni, due arpe, due chitarre elettriche, due pianoforti e percussioni.
Su tutto domina la sensazione di una profonda comprensione dell’opera pittorica di Vermeer, di quella sospensione del tempo, di quella felicità esclusiva e venata di malinconia e ansia, nella quale l’esterno è sempre alluso (una lettera, una finestra, una porta aperta), ma al tempo stesso tenuto fuori dallo spazio artistico e psicologico; un lavoro in cui realismo e sogno sembrano fondersi in un’unità inscindibile. Un’opera davvero bellissima.