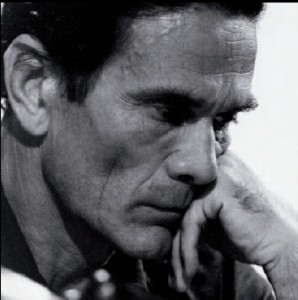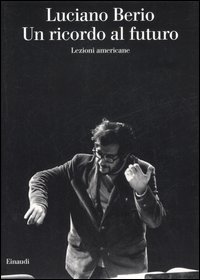Il 24 aprile scorso sono stati pubblicati i nomi dei vincitori del Premio Abbiati; la cerimonia di consegna, come un po’ pomposamente si chiamano queste occasioni, si terrà il 29 maggio prossimo al Teatro Sociale di Bergamo. In un precedente post, in margine ad alcune osservazioni sul Pulitzer Price, avevo manifestato una certa insofferenza nei confronti dei premi musicali italiani e dei loro meccanismi di assegnazione. L’Abbiati è il più prestigioso e ambìto di questi, forse l’unico che sappia ancora dire qualcosa al mondo musicale, e quindi vale la pena di osservarlo con attenzione.
Il premio e i suoi princìpi (o prìncipi?)
Intitolato al musicologo Franco Abbiati, per quasi quarant’anni critico del “Corriere della Sera”, il “Premio della critica musicale” viene assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali fin dal 1980 (per la precisione, l’associazione è nata nel 1986 proprio intorno alle riunioni che da diversi anni si tenevano a Bergamo per l’assegnazione del premio). Per capire che cosa rappresenti nello spazio culturale italiano (e nei desideri di chi ogni anno se ne assume le fatiche), vale la pena di citare un brano tratto dal sito dell’Associazione:
Attraverso i vincitori del Premio Abbiati, l’Associazione nazionale critici musicali ha dato spazio alle realtà locali che rappresentano l’autentica ricchezza della vita musicale italiana e che non hanno la visibilità dei grandi enti pur avendone, talvolta, l’importanza culturale. Allo stesso modo l’Associazione si è impegnata a ricordare il lavoro isolato e silenzioso di personaggi non riconosciuti dal “potere” né dai mass-media (operatori artistici, didatti, editori, “maestri” di vita non solo musicale), e a segnalare il rilievo intellettuale di fatti o manifestazioni che hanno indirizzato la vita musicale del nostro paese. Eloquente annuario più che pagella l’albo d’oro del Premio Abbiati è una sorta di promemoria artistico di oltre un quarto di secolo di musica in Italia, ma è stato anche un trampolino di lancio per giovani artisti e una dichiarazione di fiducia nei confronti di realtà poco considerate. Oltre a essere lo strumento privilegiato dell’Associazione per prese di posizione ‘politiche’, talvolta fortemente critiche, nei confronti di cruciali questioni istituzionali e legislative.
La frase sull’albo d’oro riflette l’antico ossimoro dei premi: un premio dovrebbe fare onore a qualcuno, ma onorando chi è davvero meritevole, in fondo onora soprattutto se stesso e chi lo conferisce. In questo senso, ogni premio è uno scambio: l’autorevolezza dell’artista premiato riconosce e manifesta l’autorevolezza dei premianti. Lo sapeva molto bene l’amato Thomas Bernhard, che con i premi intrattenne sempre un rapporto di amore-odio – con netta prevalenza dell’odio – e che in più di un caso si scagliò con terrificante violenza contro questo meccanismo infernale. Nel caso di un premio conferito da un’associazione di critici musicali, poi, la faccenda si fa ancora più complicata; certo, sempre meno complicata di quando sono gli organizzatori musicali a premiare i critici (vedi per esempio il Premio D’Arcangelo, che per fortuna consiste in 50 bottiglie di vino). Discorso ancora a parte, i premi per la critica musicale, in cui i critici stessi se la cantano e se la suonano da soli. L’apoteosi dell’autoreferenzialità, insomma.
Un luccicante “albo d’oro”
Ma tornando all’Abbiati, il cosiddetto albo d’oro è effettivamente un ritratto molto vivace della vita musicale italiana, con una netta prevalenza dei valori spettacolari (come in fondo è prevedibile data la composizione della giuria). Vediamo un po’, per esempio, i direttori d’orchestra. Si parte con un buffo ex-aequo Abbado-Muti (una specie di Camp David?) nella prima edizione 1980–81 – negli anni i premianti ripareranno: Muti viene ripremiato nell’88–89, Abbado nel 2000-01. In ogni caso il quadro rispecchia correttamente il meglio della vita musicale italiana (e naturalmente non solo): si comincia con i giganti storici (Bernstein, Kleiber, Celibidache, Gavazzeni, Sawallish ecc.), poi piano piano la rosa si apre e con andate e ritorni (Temirkanov vince due volte) si vede scorrere tutto il meglio che il setaccio italiano ha trattenuto dalla scena mondiale. Quest’anno il vincitore è Roberto Abbado: molto meritato e puntuale, si potrebbe dire, dati i begli spettacoli che ha inanellato nel 2008, in Italia e all’estero.
Ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto per quasi tutte le altre categorie. I registi, per esempio. Si parte con Strehler, e poi via via, compaiono gli autori, a volte accompagnati dagli scenografi, di tanti bellissimi spettacoli italiani; in più di un caso la scelta è abbastanza ardita, in altri più scontata: Ronconi-De Simone-Chéreau-Pizzi-Asari-Cobelli-Ronconi (e due)-Vick-Krämer-Ronconi/Palli (e tre)-Terleckij/Hugues-Wilson-Zeffirelli-De Ana-Vick (e due)-De Monticelli-Pountney/Bjorson-Krief-De Ana (e due)-Moschopoulos/Fotopoulos-Carsen-Martone-Medcalf-Barberio Corsetti-Michieletto. Quest’anno il premiato è Tcherniakov per il Giocatore della Scala. Anche per i cantanti, una scelta oculata che rispecchia una frequentazione continua della realtà musicale. I critici italiani girano per i teatri, ascoltano, guardano i grandi spettacoli – quelli di cui molta parte di mondo non troverà mai i biglietti – annotano, ricordano. Giudicano spesso con equilibrio, talvolta con pigrizia, ma poi premiano ciò che è importante, significativo, grande o meno grande che sia.
Quest’anno, lo spettacolo premiato (potevano esserci dubbi?) è il Fidelio di Abbado e Kraus a Reggio Emilia. Se Abbado torna all’opera, tutto il rutilante carrozzone degli amanti dello spettacolo da imperatori converge sul miracolato teatro; due recite? che importa, quanti vuoi che siano gli aventi diritto?! 2300 posti sono anche troppi. Costi? Sono coperti degli sponsor, non stiamo a ficcare troppo il naso, che poi non ci invitano più. Così è ovvio, non c’è gara. Certo, la difesa delle realtà locali che sono la ricchezza della vita musicale italiana, così com’era scritto nel fervorino dell’associazione, qui prende un significato tutto particolare; ma d’altro canto, parlare di teatro d’opera oggi richiede un “razionale e lucido pessimismo”, come dice la motivazione del premio al Fidelio. E in ogni caso si sa che le polemichette negli anni si perdono, ma l’albo d’oro rimane, lasciando al mondo un’immagine di eccellenza assoluta. E così, effettivamente, è. Ha ragione il sito, l’albo d’oro presenta un Italia dello spettacolo lirico viva e creativa. Forse con un’eccezione…
Ma siamo sicuri che la musica di oggi sia proprio questa?
Ed ecco che si ritorna a quanto si disse a proposito del Pulitzer. Certo, quel famoso (ma anche discusso, come tutto, dappertutto!) premio si limita alla creatività statunitense, e in questo senso il gioco potrebbe sembrare più semplice. Il premio Abbiati riflette invece la realtà spettacolare: cosa i critici hanno ascoltato e visto. Eppure, a un normale ascoltatore curioso della musica d’oggi che scorresse la lista dei premiati per la categoria “novità assoluta per l’Italia”, potrebbe anche prendere una stretta al cuore. Stockhausen-Donatoni-Nono-Boulez-Togni-Manzoni-Guarnieri-Kurtág-Boulez (e due)-Sciarrino-Gubaidulina-Clementi-Rihm-Berio-Holliger-Berio (e due)-Grisey-Henze-Kagel-Boulez (e tre)-Cappelli-Guarnieri (e due)-Vacchi/Carter-Romitelli-Kurtág (e due)-Lachenmann-Fedele. In 28 anni di storia musicale, l’unico americano premiato è stato Carter (però a metà con Vacchi). L’intera stagione del neoromanticismo, dei post-minimalisti dei non-avanguardisti è passata inosservata. Non un solo maverick, di qualunque colore, paese, visione o credenza (in questo senso, forse solo Gubaidulina).
Certo si potrà obiettare: il premio riguarda le prime esecuzioni assolute in Italia. Non è colpa dei critici se Andriessen o Reich o Adams (e questi non sono certo maverick) non vengono a rappresentare le loro cose per la prima volta da noi; piuttosto prendetevela con gli organizzatori musicali. Va bene. Certo che però quel Boulez premiato tre volte come compositore per Repons (1983−84), Le Visage nuptial (1988−89) e Sur incises (1999−2000), poi, naturalmente, una quarta come direttore (1986−87): non è che la cosa faccia proprio pensare a un grande sforzo di autonomia, vitalità culturale e curiosità intellettuale.
Quest’anno il premio è andato alla Phaedra di Henze del Maggio Musicale Fiorentino; in questo caso il premio non permette alcuna polemica, perché lo spettacolo era davvero molto bello: Henze è un maestro la cui forza emotiva e creativa sono una straordinaria benedizione per l’intero mondo dell’arte; Henze, che ha vinto tre Abbiati di cui due “speciali”, è tuttavia anche il massimo allontanamento consentito dal mainstream della musica contemporanea in Italia; in ogni caso “consentito” adesso, perché quarant’anni fa lo si copriva di fischi. Altro caso, Kurtág ha vinto due volte, se non si conta il premio al Festival Kurtág di “Milano Musica”; Kurtág prenderà quest’anno anche il Leone d’Oro alla carriera a Venezia. È un grande compositore, e queste convergenze non dovrebbero stupire.
E allora?
E allora la tristezza non viene dalle singole e isolate assegnazioni, tutte più o meno sacrosante dal punto di vista del valore assoluto (difficile avere un quadro sufficientemente completo di ogni singolo anno per potersi esprimere sul valore relativo); la tristezza viene dall’abissale distanza che divide questa ‘complessiva’ visione da parte della critica, rispetto alla realtà della vita musicale odierna. E parlo della realtà della musica che si ascolta, si esegue e si “consuma”, in Italia come nel resto del mondo. Una distanza che nessun’altra categoria premiata dai “giurati” dell’Abbiati mi pare rispecchiare. Perché?
Nella foto un istante della Phaedra di H.W. Henze rappresentata al Maggio Musicale Fiorentino.